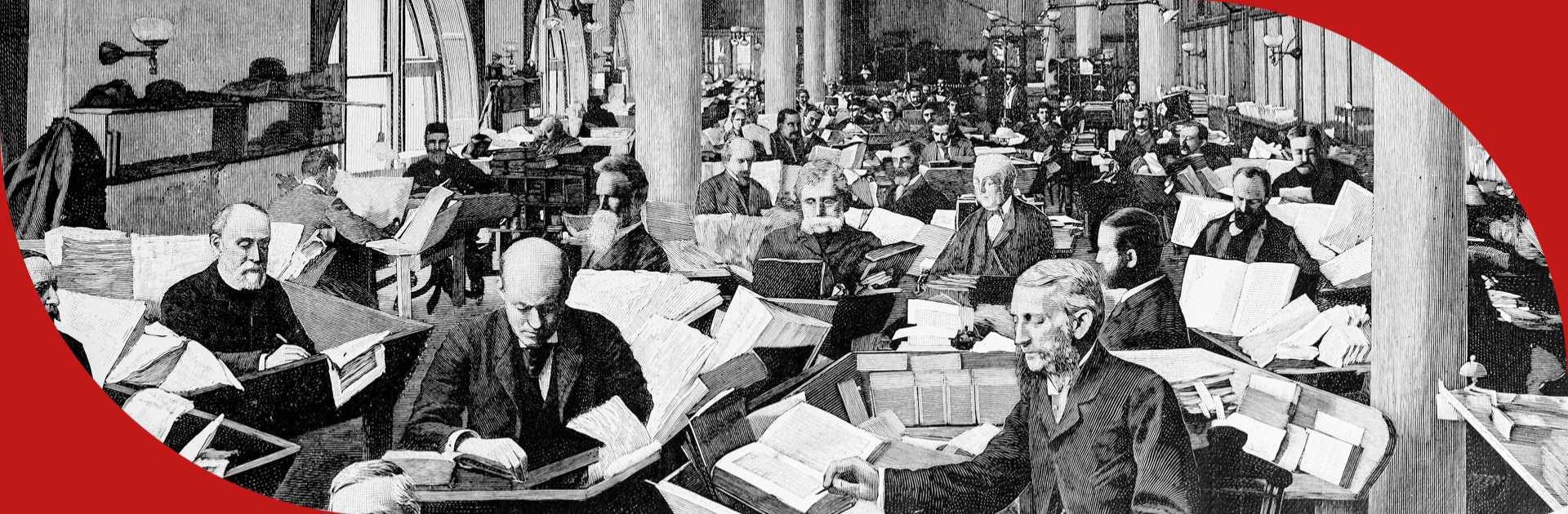
IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI...
Come il giornalismo può sopravvivere nell’era dell’AI: il capitale che non si vede ma fa la differenza
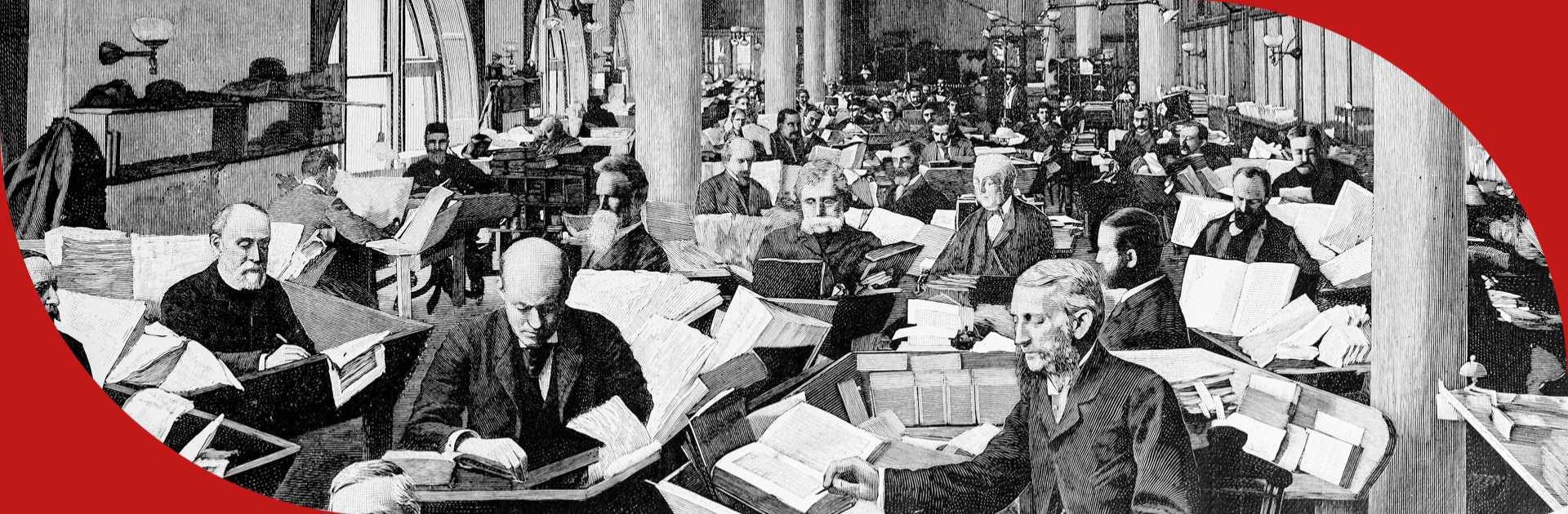
IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI...
Come il giornalismo può sopravvivere nell’era dell’AI: il capitale che non si vede ma fa la differenza
A cura di Giuseppe Francaviglia, giornalista e referente progetto 360INFO
Non saranno gli algoritmi a salvare il giornalismo. Nell’era dell’intelligenza artificiale, le redazioni che vogliono sopravvivere devono puntare su ciò che le macchine non possono replicare: l’autorevolezza di una testata, la relazione diretta con i lettori e il capitale umano di giornalisti e professionisti capaci di interpretare la realtà. È quanto emerge dallo studio “Knowledge capital in newsrooms: brand, audience & talent in the AI-mediated era”, pubblicato a luglio 2025 dal Reuters Institute.
L’impatto dell’IA sta già trasformando il modo in cui le notizie vengono prodotte, distribuite e consumate. Chatbot che rispondono direttamente alle domande degli utenti, senza bisogno di cliccare sui link, e modelli linguistici che rielaborano articoli spesso senza citare la fonte, ostacolano la visibilità dei brand giornalistici e quindi anche la sostenibilità economica dell’intero settore.
In questo scenario, la via da intraprendere per garantire un futuro alle redazioni è investire nel cosiddetto knowledge capital: l’insieme di attributi unici e immateriali che rappresentano il vero vantaggio competitivo delle testate giornalistiche. Questo “capitale di conoscenza” può assumere varie forme ma, parlando di newsroom, è possibile identificare quattro pilastri che costituiscono la base per il futuro di un media giornalistico.
L’autorevolezza del brand
Il primo pilastro è il brand. Non si parla ovviamente di un semplice logo, ma della somma di reputazione, identità editoriale e coerenza. In un ecosistema informativo basato sui social, il brand giornalistico rischia di diventare invisibile. Senza riconoscibilità e fiducia, la qualità del contenuto non basta. Le redazioni devono quindi prestare grande attenzione alle citazioni, negoziare con attenzione accordi con le piattaforme e sviluppare prodotti capaci di vivere anche fuori dal loro perimetro.
I casi studio analizzati dal Reuters Institute mostrano come i grandi gruppi abbiano cercato di estendere la forza del proprio brand in direzioni inedite, dagli eventi alla formazione. Il Financial Times ha sviluppato FT Strategies, società di consulenza per altre redazioni, mentre Condé Nast ha lanciato corsi di moda e giornalismo legati a Vogue. Anche il New York Times ha sperimentato programmi educativi.
Tutte queste iniziative partono da un presupposto: se i contenuti rischiano di essere riprodotti da chiunque, ciò che resta unico è il valore intrinseco al brand e la fiducia che ispira.
Pubblico come capitale, non come metrica
Il secondo asse riguarda l’audience. I lettori non sono soltanto consumatori, non sono esclusivamente click, ma rappresentano una risorsa strategica. Coltivare rapporti diretti — attraverso newsletter, app, community, eventi — permette di ridurre la dipendenza da “intermediari” come social media, motori di ricerca e chatbot.
Strategie rivolte ai lettori sono state introdotte per esempio da The Telegraph, che ha creato sezioni di domande e risposte con i lettori, portando a nuovi spunti giornalistici e a una maggiore fidelizzazione. Il magazine statunitense The Atlantic ha invece puntato sulle app e sui giochi interattivi per avvicinare un pubblico giovane, raggiungendo oltre un milione di abbonati. L’audience, in questa visione, diventa co-creatrice di valore, capace di indirizzare linee editoriali e prodotti.
Il talento come bene da valorizzare
Il terzo pilastro è il talento dei professionisti che compongono la redazione. Giornalisti, redattori, ma anche figure ibride come data analyst, product manager e specialisti di etica dell’IA. Sono loro a trasformare strategie in contenuti e prodotti. Eppure molte organizzazioni trattano i professionisti come costi, non come asset da preservare.
La perdita di un reporter esperto non si misura solo nel breve termine, ma incide sulla capacità futura di attrarre pubblico, aumentare l’autorevolezza della testata e innovare. Il talento non va visto, quindi, come spesa ma come capitale strategico da trattenere, sviluppare e amplificare.
Ciò significa mappare le competenze interne – spesso più ricche di quanto emerga nei ruoli formali – e investire in autonomia, riconoscimento diffuso e collaborazione tra team.
Il valore della memoria interna
Accanto a questi tre pilastri c’è poi un quarto ingrediente, forse meno tangibile ma senza dubbio di enorme valore: la conoscenza istituzionale, e cioè il capitale strutturale formato dall’insieme dei processi interni codificati, dalla conoscenza degli step organizzativi e dei procedimenti redazionali.
Infatti, se un giornalista lascia la redazione sparisce con lui anche un pezzo di quelle conoscenze che, in mancanza di sistemi di archiviazione, condivisione e valorizzazione, sono destinate a evaporare – generando il cosiddetto “knowledge leakage”.
Senza strumenti per conservare e condividere queste risorse, le redazioni rischiano di disperdere patrimonio intellettuale ogni volta che una persona lascia l’azienda. Alcuni gruppi media hanno sperimentato soluzioni innovative per contenere questo rischio.
In questo senso la tecnologia può senza dubbio essere d’aiuto, e così il media statunitense Gannett sta sperimentando un assistente digitale per l’inserimento dei nuovi assunti: un archivio intelligente che raccoglie procedure, policy editoriali, linee guida etiche. Così la conoscenza diventa accessibile e replicabile, riducendo dispersioni e tempi di integrazione.
Oltre l’intelligenza artificiale
Gli strumenti di intelligenza artificiale non sono necessariamente una minaccia per le redazioni e per il giornalismo in generale. Se è vero che da un lato strumenti come Chat-GPT possono minacciare l’attribuzione dei contenuti e ridurre il traffico diretto ai siti di informazione, dall’altro offrono aiuto per organizzare e valorizzare la conoscenza interna, rendere più efficiente l’onboarding dei nuovi assunti e valorizzare archivi e banche dati. Tutto questo però a patto che vi siano basi solide su cui costruire. E queste basi sono riconducibili proprio al knowledge capital.
In questo senso è necessario smettere di considerare brand, pubblico e talento come concetti astratti e iniziare a trattarli come veri asset da misurare, proteggere e far crescere. Significa chiedersi se il marchio è abbastanza autorevole da resistere alle dinamiche delle piattaforme social, se la relazione con i lettori è solida anche fuori dall’online, se la conoscenza interna è documentata e accessibile, se i professionisti vengono messi nelle condizioni di restare e innovare.
Perché nell’era dell’intelligenza artificiale ciò che rende unico il giornalismo non è la capacità di scrivere un testo — quella ormai appartiene anche alle macchine — ma il capitale intangibile fatto di fiducia, competenze, relazioni e memoria collettiva.